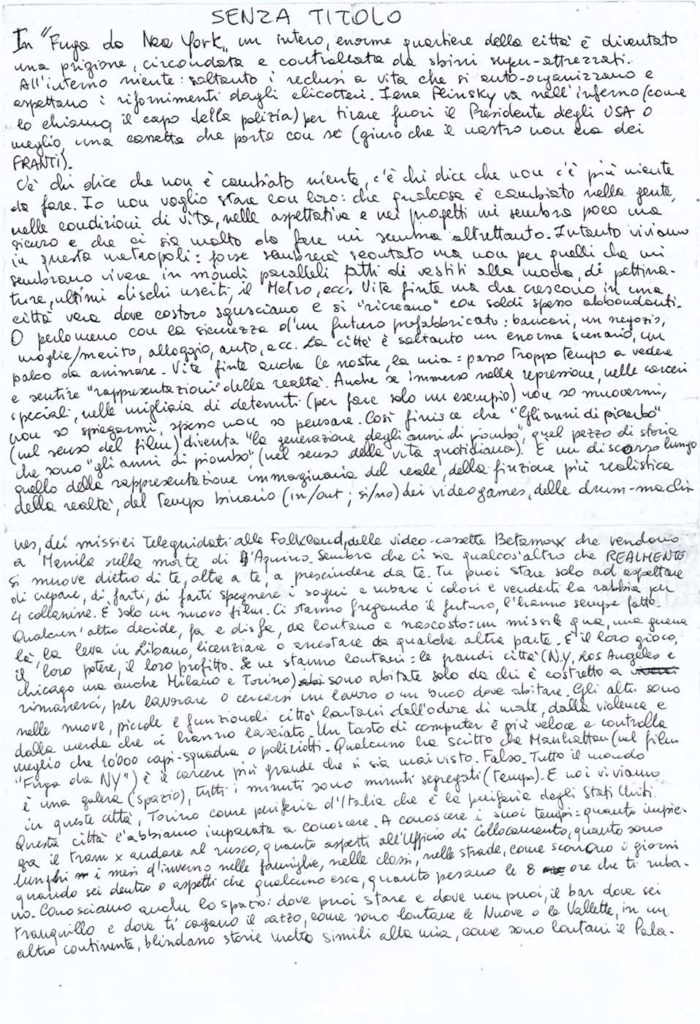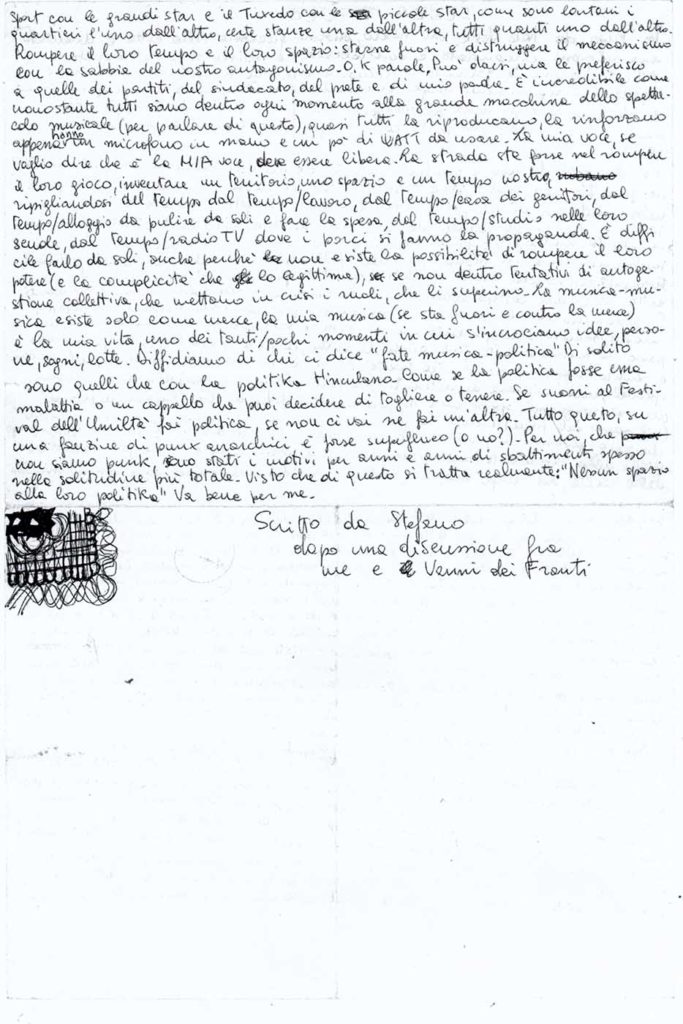“Senza titolo” di Stefano Giaccone
In “Fuga da New York” un intero, enorme quartiere della città è diventato una prigione, circondata e controllata da sbirri super-attrezzati.
All’interno niente: soltanto i reclusi a vita che si auto-organizzano e aspettano i rifornimenti dagli elicotteri. Iena Plinsky va nell’inferno (come lo chiama il capo della polizia) per tirare fuori il Presidente degli USA o meglio, una cassetta che porta con se (giuro che il nastro non era dei FRANTI).
C’è chi dice che non è cambiato niente, c’è chi dice che non c’è più niente da fare. Io non voglio stare con loro; che qualcosa è cambiato nella gente, nelle condizioni di vita, nelle aspettative e nei progetti mi sembra poco ma sicuro e che ci sia molto da fare mi sembra altrettanto. Intanto viviamo in questa metropoli: forse sembrerà scontato ma non per quelli che mi sembrano vivere in mondi paralleli fatti di vestiti alla moda, di pettinature, ultimi dischi usciti, il Metro, ecc. Vite finte ma che crescono in una città vera dove costoro sgusciano e si “ricreano” con soldi spesso abbondanti. O perlomeno con la sicurezza di un futuro prefabbricato: bancari, un negozio, moglie/marito, alloggio, auto, ecc. La città è soltanto un enorme scenario, un palco da animare. Vite finte anche le nostre, la mia: passo troppo tempo a vedere e sentire “rappresentazioni” della realtà. Anche se immerso nella repressione, nelle carceri speciali, nelle migliaia di detenuti (per fare solo un esempio) non so muovermi, non so spiegarmi, spesso non so pensare. Così finisce che “Gli anni di piombo” (nel senso del film) diventa “la generazione degli anni di piombo”, quel pezzo di storia che sono “gli anni di piombo” (nel senso della vita quotidiana). E’ un discorso lungo quello della rappresentazione immaginaria del reale, della finzione più realistica della realtà, del tempo binario (in/out; sì/no) dei videogame, delle drum-machine, dei missili teleguidati alle Falkland, delle video-cassette Betamax che vendono a Manila sulla morte di D’Aquino. Sembra che ci sia qualcos’altro che REALMENTE si muove dietro dite, oltre a te, a prescindere da te. Tu puoi stare solo ad aspettare di crepare, di farti, di farti spegnere i sogni e rubare i colori e venderti la rabbia per 4 collanine. E’ solo un nuovo film. Ci stanno fregando il futuro, l’hanno sempre fatto, Qualcun’altra decide, fa e disfa, da lontano e nascosto: un missile qua, una guerra là, la leva in Libano, licenziare e arrestare da qualche altra parte. E’ il loro gioco, il loro potere, il loro profitto. Se ne stanno lontani: le grandi città (N.Y., Los Angeles e Chicago, ma anche Milano e Torino) sono abitate solo da chi è costretto a rimanerci, per lavorare o cercarsi un lavoro o un buco dove abitare. Gli altri sono nelle nuove, piccole e funzionali città, lontani dall’odore di morte, dalla violenza e dalla merda che ci hanno lasciato. Un tasto di computer è più veloce e controlla meglio che 10.000 capi-squadra o poliziotti. Qualcuno ha scritto che Manhattan (nel film “Fuga da New York”) è il carcere più grande che si sia mai visto. Falso. Tutto il mondo è una galera (spazio), tutti i minuti sono minuti segregati (tempo). E noi viviamo in queste città, Torino come periferia d’Italia che è la periferia degli Stati Uniti. Questa città l’abbiamo imparata a conoscere. A conoscere i suoi tempi: quanto impiega il tram per andare al russo, quanto aspetti all’Ufficio di Collocamento, quanto sono lunghi i mesi d’inverno nelle famiglie, nelle classi, nelle strade, come scorrono i giorni quando sei dentro o aspetti che qualcuno esca, quanto pesano le 8 ore che ti rubano. Conosciamo anche lo spazio: dove puoi stare e dove non puoi, il bar dove sei tranquillo e dove ti cagano il cazzo, come sono lontane le Nuove o le Vallette, in un altro continente, blindano storie molto simili alla mia, come sono lontani il Palasport
con le grandi star e il Tuxedo con le piccole star, come sono lontani i quartieri uno dall’altro, certe stanze una dall’altra, tutti quanti uno dall’altro. Rompere il loro tempo e il loro spazio: starne fuori e distruggere il meccanismo con la sabbia del nostro antagonismo. OK parole. Può darsi, ma le preferisco a quelle dei partiti, del sindacato, del prete e di mio padre. E’ incredibile come nonostante tutti siano dentro ogni momento alla grande macchina dello spettacolo musicale (per parlare di questo), quasi tutti la riproducano, la rinforzino appena hanno un microfono in mano e un pò di watt da usare. La mia voce, se voglio dire che è la MIA voce, deve essere libera. La strada sta forse nel rompere il loro gioco, inventare un territorio, una spazio e un tempo nostro, ripigliandosi del tempo dal tempo/lavoro, dal tempo/casa dei genitori, dal tempo/alloggio da pulire da soli e fare la spesa, dal tempo/studio nelle loro scuole, dal tempo/radio TV dove porci si fanno propaganda, E’ difficile farlo da soli, anche perché non esiste la possibilità di rompere il loro potere (e la complicità che lo legittima), se non dentro tentativi di autogestione collettiva, che mettano in crisi i ruoli, che li superino. La musica-musica esiste solo come merce, la mia musica (se sta fuori e contro la merce) è la mia vita, uno dei tanti-pochi momenti in cui si incrociano idee, persone, sogni, lotte. Diffidiamo di chi ci dice “fate musica – politica”. Di solito sono quelli che con la politika inculano. Come se la politica fosse una malattia o un cappello che puoi decidere di togliere o tenere. Se suoni al Festival dell’Umiltà fai politica, se non ci vai ne fai un’altra. Tutto questo, su una fanzine di punk anarchici è forse superfluo (o no?), Per noi, che non siamo punk, sono stati i motivi per anni e anni di sbattimenti spesso nella solitudine più totale. Visto che di questo si tratta realmente: “Nessun spazio alla loro politika”. Va bene per me.
Scritto da Stefano dopo una discussione fra me e Vanni dei Franti